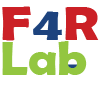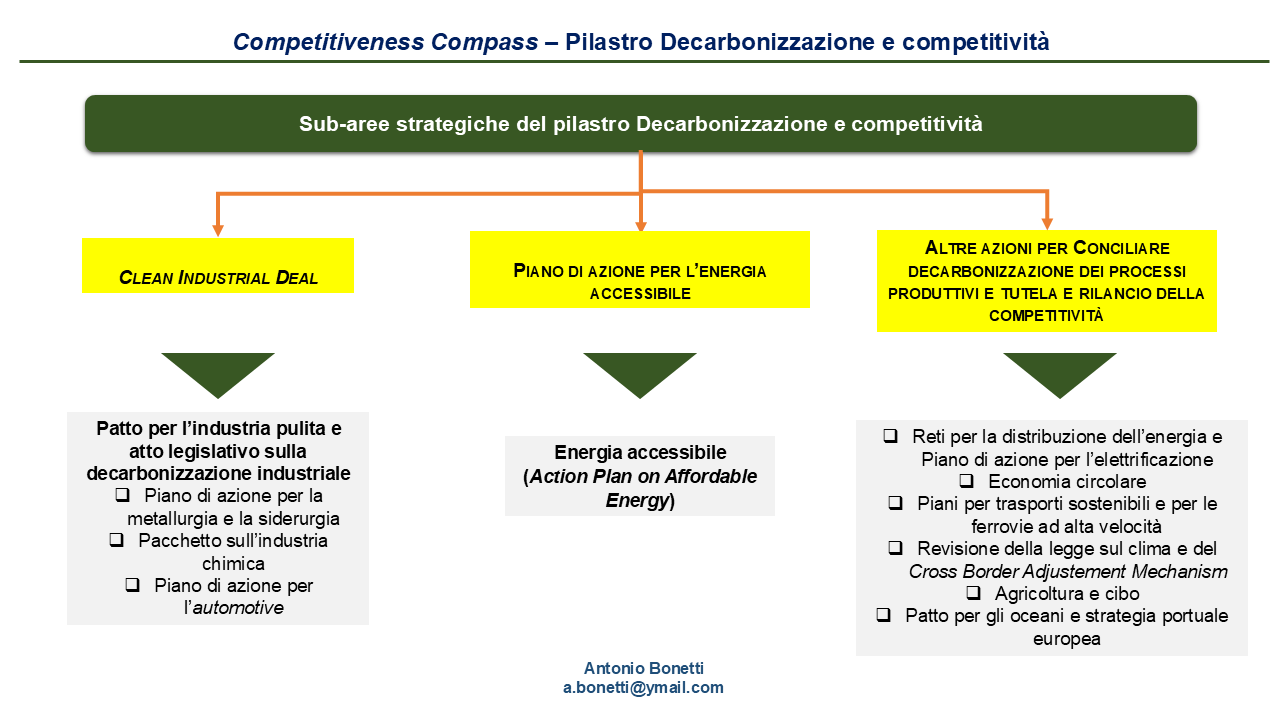Entro fine novembre dovrebbe essere rilasciato l’Avviso 2024 del Fondo Nuove Competenze.
Il Fondo Nuove Competenze era stato varato in via sperimentale dall’art. 88 del DL 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio” del 19 maggio 2020) allo scopo di sostenere le imprese nella difficilissima fase più drammatica della pandemia e, soprattutto, rilanciare le attività di rafforzamento delle competenze degli addetti quale leva strategica per la competitività.
Tale strumento, dopo l’avvio sperimentale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione (PON SPAO) del periodo 2014-2020 (cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo), è stato poi inserito nel Piano nazionale Nuove Competenze (PNC), che è uno dei pilastri della Componente M5C1 Politiche per il lavoro del PNRR. In particolare, il PNC è una delle due pietre angolari della Riforma 1.1. Politiche attive del lavoro e formazione, inserita nella Sub-componente M5C1.1 Politiche Attive del Lavoro e sostegno all’occupazione del PNRR. Tale Sub-componente, nella fase attuale, è il vero motore del percorso di progressivo rafforzamento delle Politiche Attive del Lavoro (PAL) e, quindi, il nuovo Avviso a valere sul FNC dovrebbe essere informato non solo a logiche di supporto indiretto alla competitività delle imprese, ma anche a logiche di tutela dell’occupabilità degli addetti, in particolare di quelli più avanti nell’età, a maggior rischio di dispersione delle competenze formali e informali.
Read more →